Il liuto e le cicatrici di Danilo Kiš
Il volume raccoglie testi ritrovati dopo la morte dello scrittore che, secondo l’eccellente curatrice Mirjana Miočinocić, erano almeno in parte destinati a un altro suo libro: l’Enciclopedia dei morti. Kiš ci racconta di esistenze segnate dall’esperienza dell’esilio (Il senza patria), da un dolore inconsolabile (Jurij Golec), da una verità che si finge di non conoscere (Il liuto e le cicatrici), dal presagio di una morte che si traveste da sogno (Il maratoneta e il giudice di gara), dalla violenza ottusa del potere (Il poeta) o dall’urgenza di mettere ordine nella propria vita, quasi fosse una partita doppia (Il debito). Si tratta di vite più o meno comuni, ma velate da una malinconia e da una fatica esistenziale così profonde da rendere la morte un evento quasi agognato o comunque da attendere con serenità.
Kiš, come riporta la quarta di copertina, indaga il rapporto fra il nostro destino ultimo e la necessità di dover comunque vivere qui e ora, anche grazie al valore quasi salvifico della scrittura, vera e propria “forma di sopravvivenza”. Lo fa perchè, come scrittore, “deve fare intravedere il grande tema della morte perché l’uomo sia meno superbo, meno egoista, meno malevolo e, d’altra parte, deve dare un senso alla vita”, sapendo però che “nei momenti cruciali le risposte non si trovano nei libri”. Ed è impossibile trovarle lì quando si è consapevoli di poter far affidamento solo sul proprio essere uomini: “mi sono messo a cercare quei libri che potevano darmi la forza di sopravvivere. E sono arrivato alla tragica conclusione che tutti i libri di cui mi ero nutrito per decenni in quel momento non erano in grado di aiutarmi. Non parlo dei libri sacri e degli antichi saggi; per quelli non ero pronto, mi mancava il punto di partenza: la fede in Dio”.
|
#fallabreve: Voci aggiuntive dell’unica Enciclopedia in cui prima o poi saremo citati tutti. |
 |
L’Istituto per la Regolazione degli Orologi di Ahmet Hamdi Tanpinar
Einaudi, nella sua splendida collana Letture, pubblica la prima traduzione di quello che viene considerato uno dei capolavori della letteratura turca, pubblicato a puntate nel 1954 e in libro nel 1962, e ripescato dalla “fossa comune dell’Oblio” grazie alla segnalazione e al sostegno di Orham Pamuk, come rivela Andrea Bajani nella sua scolastica e invero non troppo brillante prefazione (almeno rispetto agli standard della collana).
La storia dell’Istituto ci viene raccontata da Hayri Idral che, arrivato al tramonto della vita, prova a mettere ordine nei suoi ricordi, anche personali. L’Istituto per la Regolazione degli Orologi è una evidente allegoria, perché dietro l’idea di stabilire una norma per regolare il “tempo”, c’è un riferimento ai sistemi totalitari che devastarono l’Europa nella prima metà del Novecento, e sullo sfondo si coglie quella tensione irrisolta fra tradizione e modernità che, da secoli, fa della Turchia una vera e propria porta di comunicazione fra Oriente e Occidente: una porta sempre più cigolante e ormai quasi chiusa, purtroppo.
Tuttavia, per un lettore semplice come il sottoscritto, queste alte considerazioni hanno un peso relativo, perchè è la gradevolezza della lettura a rivestire un ruolo preminente nel giudizio che, nello specifico, è moderatamente negativo, nonostante un inizio promettente. Non vi sono dubbi, infatti, che Tanpinar metta in scena una “satira degli «enti inutili» e della burocrazia metafisica” (satira sempre attuale, peraltro), ma è altrettanto indubbio che lo faccia in modo non sempre brillante, certamente prolisso e spesso tedioso.
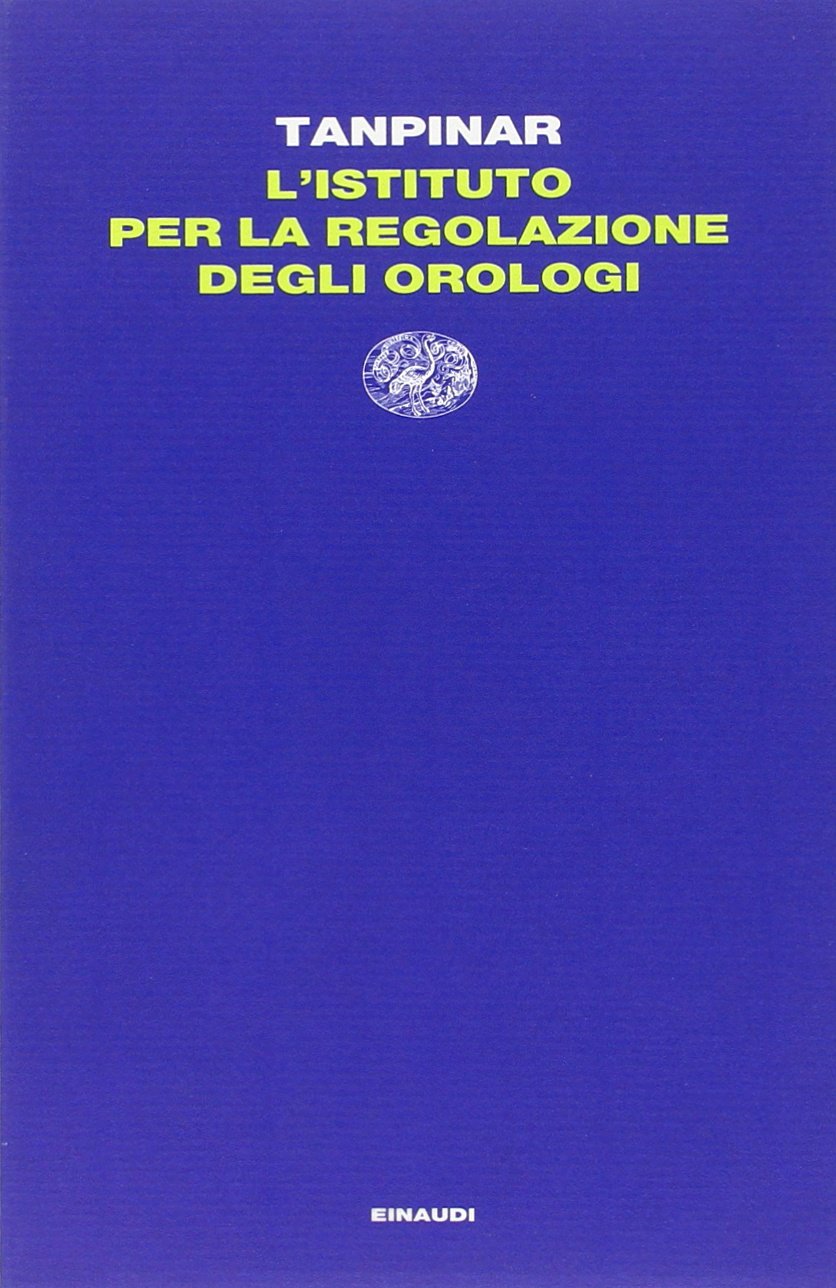 |
L’istituto per la Regolazione degli Orologi di Ahmet Hamdi Tanpinar |
L’astore di Terence Hanbury White
Chiunque può dedicare il proprio tempo a una passione, per quanto stramba ed eccentrica. Se però questo qualcuno decide di trasformare la propria passione in un’opera letteraria, esce dalla sfera della insindacabilità dei comportamenti individuali e si sottopone al giudizio del lettore.
Scritto nel 1937 e pubblicato nel 1951, questa via di mezzo fra un diario e un trattato di falconeria, si caratterizza per uno stile rigido e pomposo, ulteriormente appesantito da ripetute divagazioni piuttosto fini a se stesse. Più che la sua ripetitività, tuttavia, a renderlo particolarmente noioso è la sua assoluta mancanza di leggerezza, di ironia e, soprattutto, di un movente psicologico che giustifichi agli occhi del lettore la decisione di addestrare un astore. Diventa pertanto difficile giudicare quest’opera come qualcosa di più della cronaca stucchevole del rapporto fra un uomo e un incolpevole volatile, in cui quest’ultimo risulta alla fine molto più simpatico del primo, costretto com’è a subire ,senza alcun valido motivo (ammesso che ve ne possa mai essere uno), la crudeltà arbitraria di una scelta incomprensibile a noi prima che a lui.
E su questo non ho altro da dire.
|
L’astore di Terence Hanbury White |
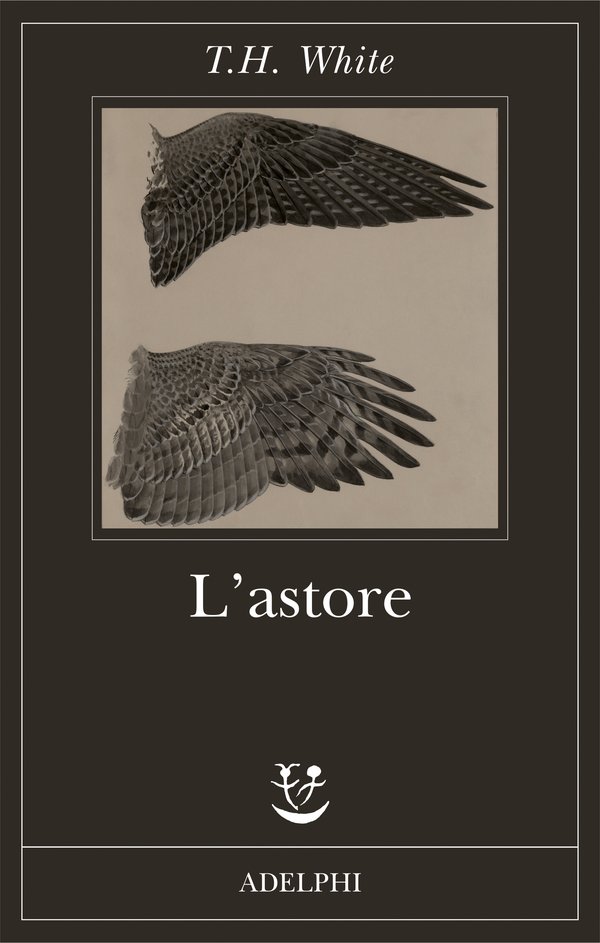 |