Sinossi (dalle note di copertina): Ci sono libri che hanno la prodigiosa, temibile capacità di dare, semplicemente, corpo agli incubi. Epepe è uno di questi. Inutile, dopo averlo letto, tentare di scacciarlo dalla mente: vi resterà annidato, che lo vogliate o no. Immaginate di finire, per un beffardo disguido, in una labirintica città di cui ignorate nome e posizione geografica, dove si agita giorno e notte una folla oceanica, anonima e minacciosa. Immaginate di ritrovarvi senza documenti, senza denaro e punti di riferimento. Immaginate che gli abitanti di questa sterminata metropoli parlino una lingua impenetrabile, con un alfabeto vagamente simile alle rune gotiche e ai caratteri cuneiformi dei Sumeri – e immaginate che nessuno comprenda né la vostra né le lingue più diffuse. Se anche riuscite a immaginare tutto questo, non avrete che una pallida idea dell’angoscia e della rabbiosa frustrazione di Budai, il protagonista di Epepe. Perché Budai, eminente linguista specializzato in ricerche etimologiche, ha familiarità con decine di idiomi diversi, doti logiche affinate da anni di lavoro scientifico e una caparbietà senza uguali. Eppure, il solo essere umano disposto a confortarlo, benché non lo capisca, pare sia la bionda ragazza che manovra l’ascensore di un hotel: una ragazza che si chiama Epepe, ma forse anche – chi può dirlo? – Bebe o Tetete.
Non v’è dubbio che, come recitano le note di copertina, Epepe sia un libro capace di dare “corpo agli incubi”. Diretto ad Helsinki per tenere una relazione ad un congresso di linguistica, “nella confusione dello scalo Budai deve aver sbagliato uscita”, salendo “su un volo diretto altrove” senza che neanche il personale dell’aeroporto se ne accorga. Essendosi assopito non appena partito, poi, non sa neanche “verso dove e per quanto tempo abbia volato”, anche perché è senza orologio, visto che “aveva intenzione di 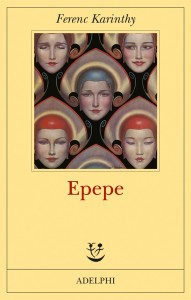 comprarsene uno là e al ritorno non voleva presentarsi alla dogana con due orologi”. Si trova così in una città del tutto sconosciuta dove, come si accorge ben presto, si parla un idioma incomprensibile anche per un eminente etimologo come lui che, “senza contare l’ungherese e il finlandese, […] aveva studiato il vogulo e l’ostiaco, poi conosceva il turco, qualcosa di arabo e di persiano, nonché il paleoslavo, il russo, il ceco, lo slovacco, il polacco, il serbocroato. Ma la parlata di quel luogo non ricordava nessuna di queste, e nemmeno il sanscrito, l’hindi, il greco antico o moderno; e non poteva essere una lingua germanica, perché Budai sapeva il tedesco, l’inglese e anche un po’ di olandese. Conosceva il latino, il francese, l’italiano e lo spagnolo, masticava il portoghese, il romeno, il ladino, e aveva nozioni di ebraico, armeno, cinese e giapponese”. Un incubo, si diceva, perché nonostante cerchi con caparbietà di utilizzare le sue capacità (peraltro non comuni) per venire a capo della situazione, ogni suo sforzo viene frustrato, come se di fronte avesse “un’equazione di sole incognite”. Sembra anzi che i suoi tentativi, sempre più disordinati, di comunicare con qualcuno o anche, più semplicemente, di capire dove sia finito, abbiano come unico risultato quello di avvitarlo in una spirale sempre più serrata di angoscia e abbrutimento.
comprarsene uno là e al ritorno non voleva presentarsi alla dogana con due orologi”. Si trova così in una città del tutto sconosciuta dove, come si accorge ben presto, si parla un idioma incomprensibile anche per un eminente etimologo come lui che, “senza contare l’ungherese e il finlandese, […] aveva studiato il vogulo e l’ostiaco, poi conosceva il turco, qualcosa di arabo e di persiano, nonché il paleoslavo, il russo, il ceco, lo slovacco, il polacco, il serbocroato. Ma la parlata di quel luogo non ricordava nessuna di queste, e nemmeno il sanscrito, l’hindi, il greco antico o moderno; e non poteva essere una lingua germanica, perché Budai sapeva il tedesco, l’inglese e anche un po’ di olandese. Conosceva il latino, il francese, l’italiano e lo spagnolo, masticava il portoghese, il romeno, il ladino, e aveva nozioni di ebraico, armeno, cinese e giapponese”. Un incubo, si diceva, perché nonostante cerchi con caparbietà di utilizzare le sue capacità (peraltro non comuni) per venire a capo della situazione, ogni suo sforzo viene frustrato, come se di fronte avesse “un’equazione di sole incognite”. Sembra anzi che i suoi tentativi, sempre più disordinati, di comunicare con qualcuno o anche, più semplicemente, di capire dove sia finito, abbiano come unico risultato quello di avvitarlo in una spirale sempre più serrata di angoscia e abbrutimento.
Il mondo in cui precipita Budai presenta coordinate spazio-temporali assimilabili a quelle di un carcere, visto che alla dilatazione del tempo legata alla forzata sospensione delle normali attività quotidiane, si accompagna una estrema contrazione dello spazio: a parte la sua stanza d’albergo, infatti, la città in cui si trova sembra un formicaio in perenne attività. Per quanto sia apparentemente immensa, straripa ovunque e a qualsiasi ora di folle oceaniche, si è costretti a file interminabili per fare qualsiasi cosa e, per non essere sopraffatti, è necessario farsi largo a forza di calci, spintoni e gomitate: un vero inferno prossemico. Eppure, nonostante sia circondato sempre e dovunque da una moltitudine di esseri umani di ogni razza e colore, il nostro eroe non riesce a trovare nessuno che possa, o voglia, aiutarlo: tutti sembrano badare esclusivamente a se stessi. Solo Epepe, la bionda ascensorista del suo albergo, si accorge di lui: un interesse abbastanza casuale, peraltro, da cui nasce un rapporto labile, allucinato e fugacissimo. Come se tutto questo non bastasse, a un certo punto anche le coordinate temporali si sgretolano in una sorta di delirio febbrile, da cui il lettore riemergerà solo alla fine del libro, senza però che nulla venga svelato sulla sorte di Budai, visto il finale niente affatto rassicurante, per quanto aperto.

Ritengo che limitarsi a sottolineare l’evidente e, forse per questo, voluto debito dell’Autore verso Kafka, sarebbe riduttivo e ingeneroso, visto che ben pochi uscirebbero indenni da un siffatto confronto. Penso anche che individuare il tema centrale del libro nella incomunicabilità, come fa Citati[1], non sia corretto o almeno non del tutto esaustivo, visto che secondo me essa è uno strumento più che un fine. E anche Carrère non centra il bersaglio quando, nella prefazione a questa nuova edizione Adelphi, scrive che, rispetto ad altri romanzi europei che “descrivono più o meno direttamente gli esperimenti sul genere umano che sono stati condotti su grande scala nell’Europa del secolo scorso”, quello di Karinthy rientra “nella narrativa pura, […] ludica, chiusa sul proprio risultato”. Perché, invece, mi sembra che Epepe sia proprio un raffinato ed ambizioso apologo sul totalitarismo, potendo perciò essere classificato a pieno titolo nella prima categoria. E allora, forse, l’incomunicabilità cui accennavo, non è tanto legata alle difficoltà linguistiche, quanto piuttosto alla paura di tutti che, dietro quell’uomo disperato e gesticolante, si nasconda un trucco, un inganno, una trappola. Insomma la mancanza di comunicazione, direi anzi il rifiuto di comunicare, è lo strumento scelto dall’Autore per rappresentare l’egoismo e l’abbrutimento morale di chi sia costretto a praticare quotidianamente la logica del mors tua, vita mea. E anche la resistenza furiosa e pervicace di Budai, non è altro che la metafora della ragione impotente di fronte all’ottusità violenta e pervasiva di una dittatura che, invece, prospera proprio sull’assoluto e ricercato sovvertimento di qualsiasi logica che non sia funzionale ad autoalimentare il proprio potere. Senza questo collegamento alla biografia di Karinthy e, per suo tramite, alla biografia collettiva degli ungheresi (e non solo), il giudizio finale sull’opera sarebbe meno benevolo.
Anche così, tuttavia, Epepe non convince del tutto. La scrittura di Karinthy, infatti, mi sembra priva dello spessore e della vivacità necessari a sviluppare per oltre duecento pagine l’idea alla base del romanzo: insomma un’opera la cui ambizione e il cui valore “politico” sono forse superiori al valore letterario.
E su questo non ho altro da dire.
#fallabreve: Guida Baedeker per l’incubo. Prefazione di Gregor Samsa.
“Epepe” di Ferenc Karinthy
Adelphi, 2015 (1970)
Traduzione di Laura Sgarioto
pp. 217
€ 18,00 (eBook € 12,99)
[1] Pietro Citati: Prigioniero di una città sconosciuta; Corriere della Sera, 6 luglio 2015: “Questo è il grande tema del libro: non poter parlare con nessuno: ascoltare risposte in una lingua indecifrabile”.